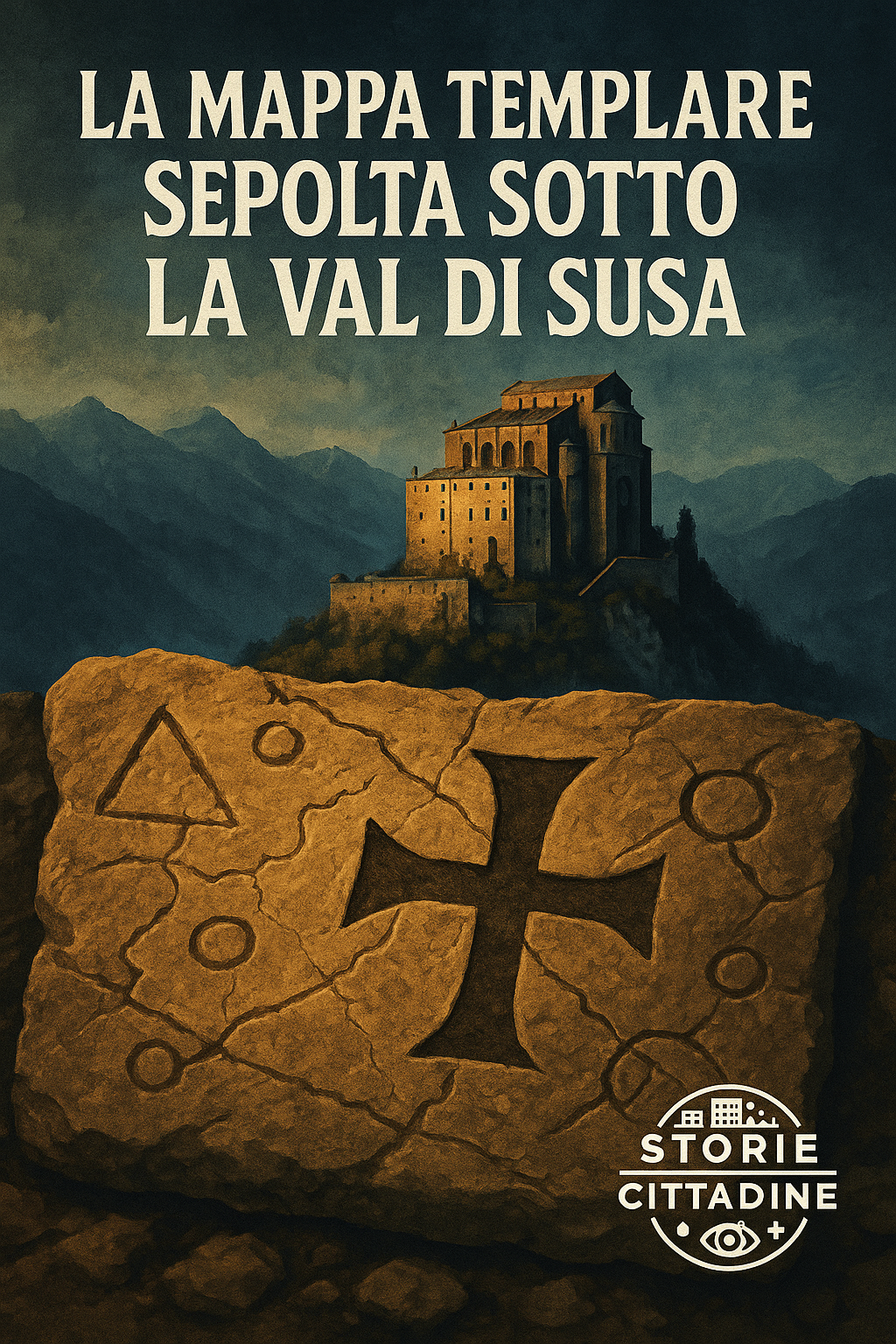
La mappa templare della Val di Susa: storia, miti e simboli sacri
Pubblicata il 02/07/2025
Tra le valli alpine piemontesi si snoda la misteriosa Val di Susa, crocevia millenario di popoli, religioni e leggende. In quest’angolo remoto d’Italia, tra vette austere e borghi medievali, si racconta di una “mappa templare” nascosta nel paesaggio stesso. Secondo la tradizione locale, l’abbazia della Sacra di San Michele – simbolo del Piemonte arroccato sul Monte Pirchiriano – sarebbe parte di un percorso sacro che collega sette santuari dedicati a San Michele lungo tutta l’Europa, da Skellig Michael in Irlanda fino al Monte Carmelo in Terra Santaleviedelmistero.wordpress.com. In un contesto siffatto, fatte risuonare le antiche pietre e ascoltato il vento tra le incisioni rupestri, la Valle di Susa si presta a divenire terra di confine tra storia documentata e affascinanti ipotesi esoteriche.
Presenza templare in Piemonte e in Val di Susa
I Cavalieri del Tempio ebbero una presenza significativa in Piemonte già dal XII secolo. Fonti storiche documentano che “il più antico insediamento templare in Piemonte, ai piedi del sistema viario alpino, era quello di Susa, datato 1170, con un ospedale per i pellegrini dedicato a Santa Maria”iltorinese.it. L’Ordine del Tempio controllava vie di comunicazione e sostegno ai pellegrini, situando le proprie precettorie presso corsi d’acqua, valichi alpini e paesi lungo le principali vie di transito del Piemonteiltorinese.itiltorinese.it. Gli studiosi moderni, come l’antropologo Massimo Centini e la storica Bianca Capone Ferrari, hanno indagato questi insediamenti in opere oggi di riferimentoiltorinese.it. In Val di Susa i Templari arrivarono «verso la fine del XIII secolo»iltorinese.it; oltre alla città di Susa, hanno lasciato tracce in alcune località vicine, per esempio croci scolpite nel sagrato di San Giorio di Susailtorinese.it. In generale, i templari difendevano abbazie, conventi e monasteri lungo le vie di pellegrinaggio (dalla Via Francigena alle strade per Santiago)iltorinese.it, spesso in stretta collaborazione con l’ordine benedettino.
Le testimonianze materiali accertate sono poche ma significative. A Susa esisteva un ospedale templare dedicato a Santa Maria (non lontano dalla celebre cattedrale di San Giusto)iltorinese.itit.wikipedia.org. Anche in città come San Giorio sono state rinvenute croci templari murate nei pressi di antiche cappelleiltorinese.it. Più in generale, la bibliografia moderna descrive centinaia di insediamenti templari in Piemonte, da Ivrea a Casale Monferrato, confermando il quadro storico di un’operosa cavalleria del Tempio in terra subalpinailtorinese.it.
Luoghi simbolo e orientamenti sacri
In Val di Susa spiccano luoghi carichi di storia e simbolismo. La Sacra di San Michele – fondata tra X e XI secolo – è il più noto: posta a 962 metri di altitudine, con la sua facciata orientata verso Est secondo criteri celesti (solstizi ed equinozi)sapienzamisterica.it. L’abbazia è considerata, nella tradizione popolare, parte di una linea sacra michelica che attraversa l’Europaleviedelmistero.wordpress.com. Le leggende locali raccontano inoltre che proprio a San Michele avvenne un episodio memorabile: secondo il racconto, «alcuni cavalieri del Tempio sarebbero saliti alla Sacra di San Michele arrampicandosi […] sul monte Pirchiriano ottocento anni fa» per un incontro con frati ritenuti legati ai Rosacrocesapienzamisterica.it. La cronaca ufficiale non conferma questo episodio, che va considerato più come leggenda che come fatto storico documentato. Tuttavia il luogo è percettivamente ”sacro”: la pietra di cui è costruita, ricca di magnetite, inganna la bussola orientandola in direzione anomalasapienzamisterica.it, e gli studiosi del costruzionismo liturgico notano numeri e forme geometriche (il numero 16 delle colonne, quadrato del quadrato, o la Vesica Piscis impressa nei capitelli) usati simbolicamente nell’architettura dell’abbaziasapienzamisterica.it. Queste caratteristiche hanno ispirato congetture di “geometria sacra” alla base della costruzione, benché manchino fonti storiche dirette che le colleghino a piani iniziatici templari.
Altri luoghi medievali valsusini sono lo spoletto di San Pietro a Avigliana e la Certosa della Mortera, oltre alla chiesa di Sant’Antonio di Ranverso a Buttigliera Alta. Pur legati ad altri ordini (gli Antoniani e i Cistercensi Mauriziani), essi punteggiano il territorio come una serie di tappe sacre a poca distanza l’una dall’altra, creando idealmente una “griglia” di edifici monastici. Se in questa griglia inseriamo anche San Michele, si ottiene un disegno simbolico che alcuni interpretano come antica mappa spirituale: non vi è però consenso accademico su tali allineamenti.
Petroglifi, megaliti e antichi percorsi
La sacralità della Val di Susa affonda radici antichissime. Le montagne custodiscono petroglifi e pitture rupestri dell’età del Bronzo e del Ferro, soprattutto nella zona di Mompantero e Chiomonteparchialpicozie.it. I Parchi Alpi Cozie segnalano che qui “la concentrazione di incisioni figurative a martellina ne fa un complesso abbastanza raro in Piemonte”parchialpicozie.it, con scene di guerrieri, asce e figure antropomorfe. Anche Monte Musinè – la montagna che sovrasta l’imbocco della valle – è disseminato di coppe e segni preistorici attribuiti ai Celti. Un tempo luogo di raccolta dell’opale (pietra considerata sacra) e di culto druidico, il Musinè è tuttora considerato dai cultori del mistero un nodo energetico. Alcuni vi vedono un “gigantesco catalizzatore di energie benefiche” e perfino “una sorta di finestra aperta su un’altra dimensione”shan-newspaper.com; leggende narrano di luci nei boschi, incontri con spiriti e apparizioni nei cieli serali (già nel 966 d.C. testimoni raccontarono globi infuocati sopra il valloneshan-newspaper.com).
Tali elementi naturali – rocce incise, menhir e coppelle – alimentano la suggestione che sia nascosta una mappa sacra nel territorio. Si è ipotizzato un disegno sotteso che unisca i siti antichi; per esempio, la successione di cerchi o triangoli formati dalle preesistenze megalitiche e dalle abbazie medievali (da San Michele a Ranverso e San Pietro) potrebbe delineare percorsi iniziatici sul modello di altri cammini sacri. Queste speculazioni integrano la geometria sacra con le linee energetiche della “terra” (energie telluriche), ma rimangono al momento suggestioni non confermate da studi archeologici ufficiali.
Graal, drago e leggende locali
Alla consueta storia documentata si affianca nel folklore un affresco di miti affascinanti. Tra questi emerge la leggenda di Rama, una sorta di Atlantide valsusina. Testi di ambito esoterico riportano cronache mitiche di una “città ciclopica” di Rama nelle Alpi Cozie, descritta come ricca di mura gigantesche in pietra, simile alle fortezze megalitiche dell’America Latinashan-newspaper.com. Secondo queste narrazioni, la città di Rama custodiva addirittura il Sacro Graal: una gemma luminosa (descritta talora come smeraldo) di immensi poterishan-newspaper.com. Non esistono riscontri storici di Rama nelle fonti accademiche; la storia sembra un miscuglio di tradizione celtica e fantasia. Su questi temi è intervenuto anche il programma televisivo Striscia la Notizia, che accenna a “teorie” su resti della città di Rama attribuiti addirittura a civiltà alienestriscialanotizia.mediaset.it.
Legata a Rama è la figura del “drago”, mitica creatura d’oro che avrebbe vegliato il Graal. Alcuni racconti parlano di un’entità mutaforma contenuta in una caverna del Monte Musinè che compariva come grande drago dorato a protezione di una gemma verdeshan-newspaper.com. Anche questa è una leggenda moderna priva di documentazione storica; tuttavia il tema del drago com’è noto è ricorrente nei racconti templari e nei miti arcaici (si pensi all’araldica templare o a San Giorgio). In Valle di Susa la storia del drago che infastidiva i pellegrini (cui San Michele sottrae con la spada) viene spesso rimessa in scena nelle colline intorno al sacrario.
Più filologicamente, alcuni studiosi alternativi collegano gli echi valsusini al Graal con il “mito di Fetonte”: secondo questa leggenda ermetica un dio (legato alle stelle del carro solare) insegnò l’alchimia e fu lasciata sul monte una grande ruota d’oro forata, la cui forma circolare evocherebbe l’idea della coppa del Graalshan-newspaper.com. Tali racconti sono tutt’altro che accreditati in ambito storico; piuttosto, riflettono un interesse New Age e neo-druido per le tradizioni locali. Storici e filologi considerano fattualisticamente i toponimi e alcuni documenti medievali, mentre affiancano le leggende come elementi di folklore.
Tra storia e mistero: il fascino di oggi
In epoche recenti la Valle di Susa è divenuta meta di viaggiatori curiosi non solo per montagne e piste, ma anche come “territorio limite” fra ragione e mistero. Tra gli escursionisti e gli appassionati di archeologia del mistero serpeggiano ancora ipotesi sulla “mappa templare” incisa nelle colline: linee immaginarie di allineamento geografico, orientamenti astronomici e correnti sotterranee rintracciabili nel paesaggio. Oggi gli studiosi riportano dati certi (archivi medievali, toponomastica templare)iltorinese.itiltorinese.it, ma non mancano interpreti avventurosi che ricercano energie telluriche e cavallereschi sigilli nella pietra di monti e castelli.
Il fascino attuale della Val di Susa sta proprio in questo confine incerto. Da un lato ci sono gli storici che analizzano documenti, confermano l’esistenza di ospedali templari e catalogano i monumenti romanici; dall’altro gli appassionati di misteri che esplorano le incisioni rupestri alla ricerca di un codice nascosto. Quella vallata è una “linea di confine” ideale: tra la cultura alpina e le grandi vie europee, tra i racconti di tradizioni antiche e il risveglio di simbolismi esoterici. Qui, come scrive un ricercatore contemporaneo, “tradizioni, leggende, fatti strani, tutto si mescola senza un confine preciso”shan-newspaper.com. E forse è anche grazie a questo miscuglio di storia e mito che la Valle di Susa continua a esercitare sul visitatore un potere di suggestione senza tempo, capace di nutrire tanto lo spirito del pellegrino quanto quello dello cercatore di enigmi.
Fonti: Siti istituzionali e ricerche storiche documentano la presenza templare in Piemonte (cfr. Centini, I Templari in Piemonteiltorinese.it; S. Maria di Susa 1170iltorinese.it). Le caratteristiche geografiche e architettoniche (linea sacra di San Micheleleviedelmistero.wordpress.com, petroglifi di Mompanteroparchialpicozie.it, misteri del Monte Musinèshan-newspaper.com) sono tratte da pubblicazioni turistiche, studi di archeologia locale e divulgazione storico-esoterica. Le leggende di Rama, Graal e “drago custodito” sono ricavate dalla letteratura mitica contemporaneastriscialanotizia.mediaset.itshan-newspaper.comshan-newspaper.com; la presente trattazione distingue esplicitamente tra i dati storici accreditati e le ipotesi narrative che li affiancano.
Commenti
Nessun commento ancora. Sii il primo!
Per commentare devi accedere o registrarti.