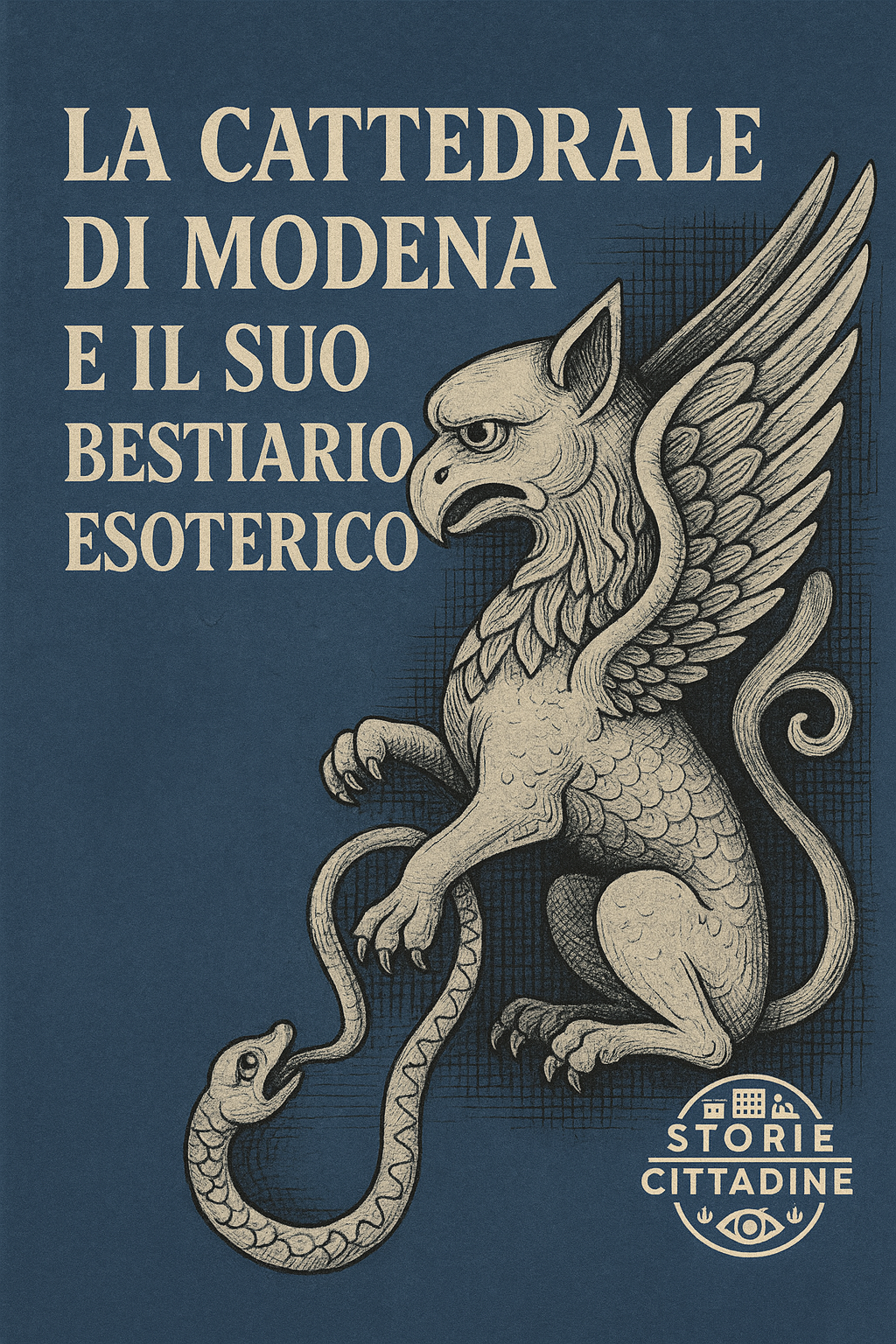
Il bestiario esoterico della Cattedrale di Modena
Pubblicata il 02/07/2025
Nel cuore di Modena, la cattedrale romanica di San Geminiano spicca con le sue linee sobrie e le pareti marmoree: eppure, chi si sofferma ad osservare i dettagli notturni delle pietre scopre un mondo nascosto di creature misteriose. Sulle arcate e i capitelli della facciata, nei portali e nelle mensole emergono sirene, leoni, grifoni, esseri ibridi e mostri “in carne e pietra” che sembrano animarsi alla luce dei lampioni. Queste sculture, parte integrante dell’architettura, intrecciano sacro e profano, raccontando storie antiche che ancora oggi affascinano il visitatore.
Contesto storico-artistico
La cattedrale di Modena, edificata a partire dal 1099 su progetto dell’architetto Lanfranco, è considerata «un supremo esempio dell’arte romanica primitiva»whc.unesco.org. Commissionata dalla dinastia canossiana, fu pensata come basilica a tre navate con cripta e matroneo sovrastante, realizzata con materiali di reimpiego provenienti dalle antiche strutture romane della cittàpatrimoniomondiale.modena.it. Alla costruzione parteciparono diversi maestri: tra questi spicca lo scultore Wiligelmo, il cui nome è addirittura inciso sul lastrone fondativo del Duomotreccani.it. Wiligelmo e altri scultori attivi tra il XII e XIII secolo decorarono l’edificio con sculture monumentali: i quattro grandi rilievi con le Storie della Genesi sopra i portali, ma anche una ricchissima decorazione di capitelli e mensole punteggiati di motivi vegetali e creature fantastiche lungo tutto il perimetropatrimoniomondiale.modena.it. Fin dall’epoca medievale l’innovativa unione tra architettura e scultura rendeva il Duomo di Modena un modello per tutto il romanico emiliano.
Il bestiario della facciata e dei portali
L’attenzione dello scultore si concentra innanzitutto sulla facciata principale. Al centro spicca il portale maggiore, attribuito a Wiligelmo, con ai lati leoni stilofori in pietra probabilmente di origine romana. L’estradosso dell’arco è intarsiato da un tralcio fitto di foglie d’acanto sorrette alla base da telamoni inginocchiati: fra i suoi intrecci si celano figure di uomini e di esseri fantastici, come basilischi, grifoni e sirenelaguidadimodena.it. Questi animali mostruosi emergono dal fogliame e conferiscono un senso di surreale fertilità e pericolo. Nell’archivolto al culmine dell’arco, a dominare è l’immagine di Giano bifronte – divinità pagana delle soglie – mentre nell’intradosso sottostante compaiono le nicchie con i profeti dell’Antico Testamento. Ai lati del grande portale Wiligelmo scolpì due pannelli con figure classicheggianti di angeli con fiaccole: da un lato è accostato un ibis, possibile simbolo della morte del peccatore, secondo gli studiosilaguidadimodena.it.
Ai lati del protiro maggiore si trovano poi altre decorazioni marmoree: angeli, animali reali e fantastici che popolano i capitelli delle loggette. Un dettaglio particolarmente curioso sono i due cervi contorni che condividono una sola testa, scolpiti sul fronte: la tradizione simbolica li interpreta come immagini di vita e morte fuse insiemelaguidadimodena.it. Sul lato sud della cattedrale s’apre la Porta dei Principi, rifatta nel Duecento, con colonnine tortili e rose scolpite. Sul fianco nord infine la Porta della Pescheria (così chiamata dal vicino mercato del pesce) offre un altro esempio curioso di scultura profana: qui gli stipiti interni raccontano il “calendario contadino” con i mesi dell’anno, e l’archivolto superiore narra una scena della leggenda arturiana. In essa sei cavalieri armati corrono verso un castello in cui una dama è prigioniera: fra di loro è esplicitamente nominato Re Artù (il secondo cavaliere da sinistra), in una delle più antiche rappresentazioni della saga arturianapatrimoniomondiale.modena.it. Questo intreccio di mito cavalleresco (ingresso degli antichi “Mesi” e nomi incisi) dimostra come all’epoca fosse comune mischiare temi biblici e profani all’interno dell’iconografia sacrapatrimoniomondiale.modena.it.
Capitelli, mensole e sculture laterali
Sui capitelli delle colonne del matroneo e nei piccoli arcatelli pensili la fantasia scultorea si scatena senza limiti. Infatti sette capitelli distinti portano figure animalesche o umane dal preciso valore simbolicoview.genially.com. Vi compaiono sirene bicaudate, sfingi, leoni accovacciati, montoni con l’aria eroica, un leone, un toro, un angelo e un’aquila, i quattro Evangelisti, e persino uomini con gli occhi spalancati che emergono dalla vegetazioneview.genially.com. Questi animali e figure mitiche sono scolpiti in rilievo nei capitelli delle arcate superiori e costituiscono un piccolo bestiario scolpito in marmo. Anche altri elementi decorativi presentano fauna: nelle mensole che sostengono le colonnine vi sono aquile spiegate o mostruose grottesche, mentre nella cripta e nel lapidario del Duomo si conservano rilievi staccati con cervi e perfino un leone divorante una predaview.genially.com.
L’insieme di queste sculture non è casuale: come sottolinea il sito ufficiale del Duomo, Wiligelmo e i suoi collaboratori arredarono l’edificio con una «splendida decorazione che popola di motivi vegetali o di esseri fantastici ogni capitello della loggia e delle semicolonne»patrimoniomondiale.modena.it. In altre parole, il Duomo di Modena è circondato da un groviglio di creature che un tempo doveva trasmettere un insegnamento morale ai fedeli. Ad esempio, le rappresentazioni degli Evangelisti (aquila, leone, toro, angelo) erano simboli riconoscibili della Bibbia, mentre ibridi e mostri ricordavano allegoricamente il male e il peccato.
Le metope dello “scrigno magico”
Agli angoli della facciata, come una sorta di cornice, sono visibili otto lastre scolpite dette metope. Ognuna di esse raffigura un’immagine insolita: animali immaginari o figure umane deformate. Nel Museo Lapidario del Duomo si può tuttora ammirare ad esempio la sirena bicaudata – una donna con due code di pesce conserte tra le mani – il cui volto è incorniciato da lunghi capelli e un sorriso “agghiacciante”fototeca.fondazioneragghianti.it. Le didascalie del Museo spiegano che le metope modenesi erano «figure mostruose complesse, quasi un campionario di deformità e strani connubi di anatomie umane e animali»fototeca.fondazioneragghianti.it. In queste analisi museali si sottolinea che «i mostri sono figure simboliche, debitrici di fonti iconografiche quali la Bibbia, i bestiari e antiche leggende […] immagine e segno della conseguenza del peccato», simboleggiando in ultima analisi eretici e peccatorifototeca.fondazioneragghianti.it. Oltre alla sirena, vi sono altro: un uomo dalle tre gambe che ricorda gli sciàpodi delle meraviglie medievali (rappresentati nella cartografia antica) e perfino una figura barbuta in postura sciamanica, che alcuni studiosi moderni hanno interpretato come un asceta indiano treccani.itmedioevoeuropeo-uniupo.com. In particolare, Davide Nobili (2023) ha proposto che un tale rilievo raffiguri “una delle meraviglie dell’Oriente” secondo l’immaginario medievale: l’uomo barbuto sarebbe infatti un sannyasi indiano in posa di yogamedioevoeuropeo-uniupo.com. Si tratta naturalmente di un’interpretazione specialistica: nessuna epigrafe medievale chiarisce questi elementi, che restano in gran parte misteriosi.
Interpretazioni ufficiali: natura e morale
Gli esperti d’arte concordano però su una lettura complessiva “ufficiale” di questo repertorio bestiale. Nel Medioevo, quando i fedeli erano in gran parte analfabeti, queste sculture avevano un valore didattico allegorico. La teologia cristiana vedeva in creature come le sirene (metà donna e metà pesce) l’emblema delle tentazioni carnali. In effetti, secondo fonti iconografiche, le sirene a due code spesso simboleggiano un ammonimento contro i peccati della carneparcodellavaldorcia.com. (Lo stesso sito culturale della Val d’Orcia nota che «secondo il pensiero cristiano le sirene […] simboleggiano i peccati della carne»parcodellavaldorcia.com.) Allo stesso tempo esiste una lettura alternativa: alcune tradizioni popolari attribuiscono alle sirene antichi significati di fertilità, legati a culti pre-cristiani (in questo caso la sirena bicaudata diventerebbe un simbolo della Dea Madre e della feconditàparcodellavaldorcia.com). Analogamente, animali feroci scolpiti sul Duomo – serpenti, leoni, draghi – erano spesso intesi come guardiani simbolici della legge divina o come demoni da cui il santo patrono (qui san Geminiano, raffigurato sul rosone) libera i fedeli. In generale, come spiegano fonti museali, le creature fantastiche del Duomo «rappresentano in immagini e segni la conseguenza del peccato», fungendo da lezioni morali visivefototeca.fondazioneragghianti.it. In tal senso, la cattedrale può essere vista come una sorta di Biblia pauperum: una Bibbia del popolo incisa nella pietra, dove ogni dettaglio invita alla riflessione sul sacro e sul profano.
Leggende, codici segreti e teorie esoteriche
Accanto a queste interpretazioni tradizionali, nel tempo sono nate anche letture più fantasiose e “misteriose” delle sculture. Alcuni autori esoterici vedono nelle pietre del Duomo tracce di simboli massonici e templari. Per esempio, il volume Modena magica ipotizza che nel grande rosone centrale sia nascosta la “firma” degli antichi muratori: la croce templare (o tau ebraico) incisa sul marmo avrebbe valore di amuleto e di codice iniziaticoacademia.edu. Seguendo queste teorie, il rosone diventerebbe un vero e proprio sigillo dell’Opera, con geometrie e numeri (24 spicchi) collegati a nozioni alchemico-cosmologicheacademia.edu. Alla stessa maniera, qualche studioso paragonando dettagli dell’architettura a strumenti da cantiere (squadra, compasso) vede reminiscenze di una Massoneria operativa medievale tramandata nei segreti costruttiviacademia.edu. Va ripetuto che tali ipotesi, benché suggestive, non trovano riscontri diretti nei documenti storici e restano per lo più nel regno della leggenda urbana.
Anche alcune storie legate ai rilievi sono ormai più leggendarie che fondate: ad esempio la figura di san Geminiano che smaschera un demone (incisa nel portale dei Principi) è stata talvolta letta come un richiamo alle imprese di san Gennaro o a santi guerrieri, ma la fonte è esclusivamente iconografica. Un caso emblematico è la Porta della Pescheria: soprannominata affettuosamente “Porta di Artù” da guide turistiche, perché nell’archivolto compare Re Artù, una signora inglese e cavalieri armatipatrimoniomondiale.modena.it. La realtà è meno fantastica: si trattava di un codificato ciclo cavalleresco allora in voga, scolpito da un ‘Maestro di Artù’ locale per narrare le favole medievali della fatica dei mesi e di una liberazione (forse ispirata al Graal)patrimoniomondiale.modena.it.
Il fascino attuale dei simboli
Oggi il visitatore moderno può guardare questi mostri di pietra con occhi diversi: non più quelli di fede medievale, ma con la curiosità di un esploratore. L’“italia proibita” del nostro titolo coglie il fascino misterico che ancora circonda il Duomo: i simboli scolpiti restano un atto di fuoriscena, un enigma aperto. Per molti appassionati di arte e di esoterismo essi sono uno specchio del passato remoto, un esempio di come l’architettura potesse scrivere storie segrete sulla pietraacademia.edu. In realtà non esiste oggi una lettura univoca: alcuni storici dell’arte mantengono le interpretazioni ufficiali, che legano gli animali a morali bibliche, mentre gli amanti del mistero continuano a inventare chiavi di lettura simboliche. Quello che rimane, al di là di ogni ipotesi, è l’emozione di vedere il mondo animale e fantastico animare la facciata di una cattedrale millenaria: un universo di forme e rimandi che continua a suscitare meraviglia e domande nel cuore dei visitatori odierni.
Fonti: studi storici e iconografici (archivio Unesco e Patrimonio Mondiale di Modenawhc.unesco.orgpatrimoniomondiale.modena.it; analisi museali e enciclopedie d’artefototeca.fondazioneragghianti.ittreccani.itparcodellavaldorcia.com); ricerche d’arte medievale (Nobili 2023medioevoeuropeo-uniupo.com); pubblicazioni e testi esoterici (Poltronieri & Fazioli 2021academia.edu). Ove citate, le interpretazioni alternative o leggendarie sono chiaramente indicate come ipotesi non provate.
Commenti
Nessun commento ancora. Sii il primo!
Per commentare devi accedere o registrarti.