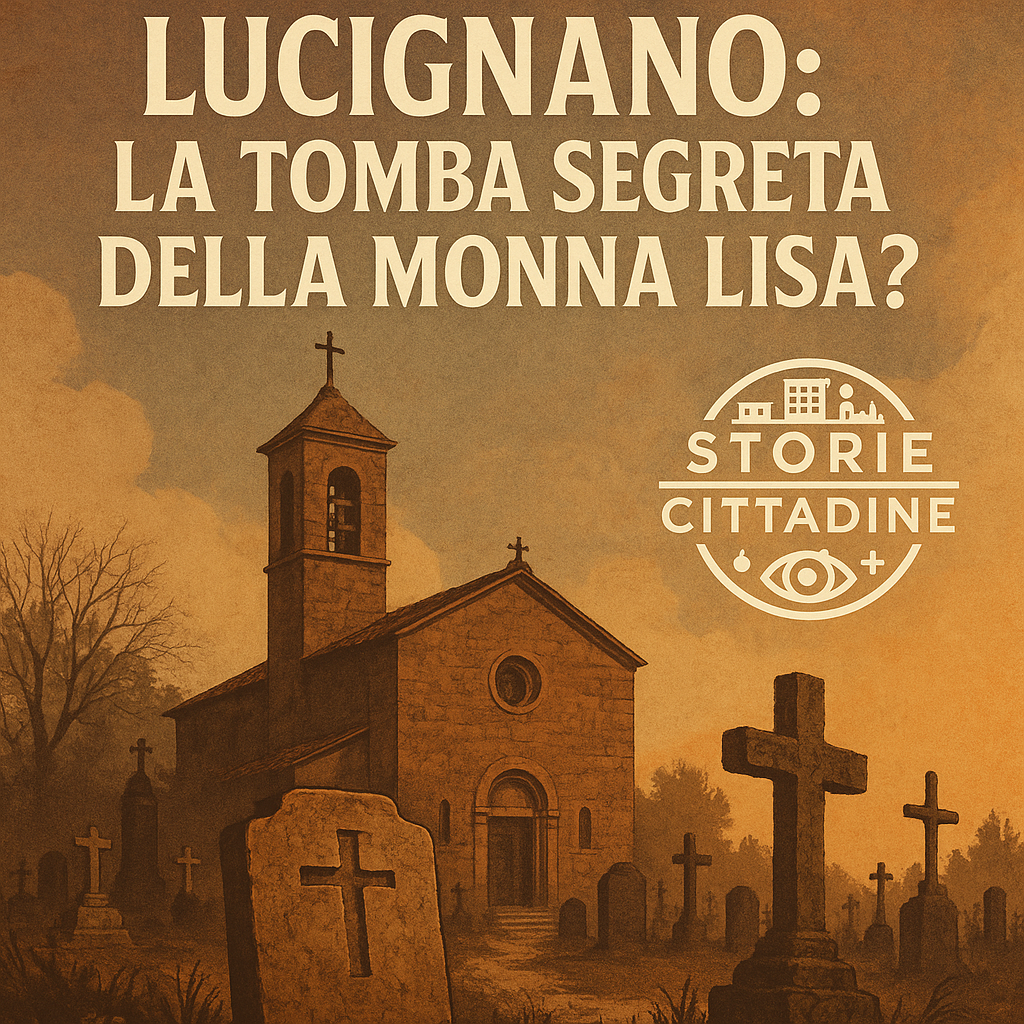
Il mistero della presunta tomba segreta di Monna Lisa a Lucignano
Pubblicata il 17/06/2025
Un enigma secolare: dov’è sepolta la Gioconda?
La Gioconda, il celebre ritratto di Lisa Gherardini dipinto da Leonardo da Vinci, è avvolta da innumerevoli misteri. Non solo la sua identità e il suo enigmatico sorriso hanno fatto discutere per secoli, ma anche il luogo della sua sepolturaresta oggetto di dibattito. Secondo i documenti ufficiali, Lisa Gherardini – meglio nota come Monna Lisa – morì a Firenze il 15 luglio 1542 e fu sepolta nel vicino convento di Sant’Orsola. Eppure, una leggenda alternativa sostiene che il suo ultimo riposo non sia affatto nel capoluogo toscano: si tratterebbe invece di una tomba segreta nascosta a Lucignano, un tranquillo borgo in Toscana, lontano dal clamore delle corti rinascimentali. Questa teoria affascinante sfida la versione canonica e getta nuova luce sull’enigmatica fine della donna più famosa mai ritratta in pittura.
La versione ufficiale e l’ipotesi alternativa
Per comprendere l’origine di questa teoria, occorre innanzitutto ricordare chi fu Lisa Gherardini. Nata a Firenze nel 1479 da una famiglia nobile, Lisa sposò il mercante Francesco del Giocondo, entrando così nella storia come “La Gioconda”. Le cronache tradizionali narrano che, rimasta vedova, Lisa si ritirò in vita monastica e morì ultrasessantenne a Firenze . La sua sepoltura fu a lungo avvolta nell’incertezza a causa della mancanza di registri conventuali dell’epoca, alimentando congetture su dove fossero finiti i suoi resti . Proprio in questo vuoto documentario si inserisce l’ipotesi alternativa: Lisa non sarebbe stata sepolta a Firenze, bensì altrove, in un luogo remoto le cui tracce affiorano nei racconti e nelle ricerche condotte nel corso del Novecento. La teoria “lucignanese” – dal nome del borgo toscano a cui viene collegata – ha origine da vicende sorprendenti e documenti inaspettati, che vale la pena ripercorrere.
Origine di una leggenda: un romanzo riaccende i dubbi
L’idea che Monna Lisa possa aver trovato sepoltura lontano da Firenze nasce agli inizi del XX secolo, quando un romanzo storico getta un’ombra di mistero sulla fine della Gioconda. Nel 1901 lo scrittore russo Dmitrij Sergeevič Merežkovskij pubblicò un romanzo dedicato a Leonardo da Vinci, in cui inserì un episodio destinato a far discutere: la morte improvvisa di Lisa Gherardini durante un viaggio lontano da casa . Nel racconto di Merežkovskij, la bella fiorentina non invecchia in convento a Firenze, ma perde la vita molti anni prima, addirittura nel 1506, durante un viaggio al seguito del marito Francesco del Giocondo . Secondo le pagine del romanzo, Monna Lisa si ammalò gravemente lungo la strada del ritorno dalla Calabria, dove Francesco si era recato per affari, e morì in “una piccolissima città sperduta” tra i monti . Quella città viene identificata con Lagonegro, un borgo dell’Italia meridionale che all’epoca rientrava nell’antica regione della Lucania . “La leggenda vuole infatti,” scrive Merežkovskij, “che la sepoltura della modella leonardiana si trovi in Lucania” . Questa sorprendente variante narrativa, pur scaturendo da un’opera letteraria, accese immediatamente l’immaginazione popolare: possibile che la vera Monna Lisa avesse davvero concluso i suoi giorni lontano da Firenze, in un paesino sperduto?
Un viaggio fatale: la storia di Lisa in Lucania
Nel dipanarsi del romanzo di Merežkovskij prende forma quella che diventerà la trama della leggenda lucana di Monna Lisa. I dettagli forniti dallo scrittore sono vividi: Lisa, ancora giovane, accompagna il marito in un lungo viaggio verso il Sud Italia, probabilmente per seguire i commerci di Francesco. Durante il ritorno, però, la sfortuna colpisce. La donna contrae un male improvviso – alcune fonti parlano di febbri malariche, altre di un’infezione alla gola – che la costringe a fermarsi in una località montana della Lucania . Si tratta di Lagonegro, piccolo centro adagiato tra i monti lucani, dove Lisa sarebbe stata accolta e curata invano. In pochi giorni, nel racconto, la “giovane fiorentina” si spegne lontana dalla sua patria . È il settembre 1506: la Monna Lisa, vittima di un destino tragico, viene consegnata per sempre alla “terra lucana” . Secondo il romanzo, il suo corpo fu sepolto lì, in un luogo segreto tra le montagne dell’Appennino lucano, davanti al Mar Tirreno che bagna quelle coste remote . Questa scena letteraria, intrisa di pathos e mistero, gettò le basi per una tradizione locale che sarebbe durata ben oltre le intenzioni dell’autore.
Indizi dal passato e ricerche sul campo
Dopo l’uscita del romanzo, la possibilità che la vera Gioconda fosse morta lontano da Firenze cominciò a circolare anche al di fuori della finzione letteraria. Storici locali e appassionati di memorie in Lucania presero sul serio la storia, al punto che già nel 1914 lo studioso lagonegrese Carlo Pesce la inserì nella sua Storia della città di Lagonegro. Pesce riferì la notizia così come l’aveva letta nell’opera russa, annotando che “forse può avere un certo fondamento storico”, pur con la cautela che meritava un racconto senza conferme documentarie dirette . Egli stesso ammise di non aver potuto verificare la veridicità della vicenda, chiedendosi se il nome di Lagonegro fosse stato messo “a casaccio” dallo scrittore russo . La mancanza di registri parrocchiali risalenti al Cinquecento (nei quali eventualmente cercare il nome di Lisa Gherardini) impediva infatti di sciogliere il dubbio . Ciò nonostante, le voci popolari continuarono a tramandare la storia di generazione in generazione, arricchendola di dettagli suggestivi. A Lagonegro si narrava che Lisa del Giocondo fosse stata sepolta proprio nella chiesa principale del paese, la secolare concattedrale di San Nicola . All’interno di quella chiesa, secondo la tradizione, vi sarebbe dunque la tomba nascosta di Monna Lisa, anche se nessuna lapide con il suo nome è mai emersa a confermarlo . La assenza di prove tangibili non fece però venir meno la passione con cui i lucani custodivano questo segreto: anzi, alimentò ancor di più il fascino del mistero.
Dal mito alla cronaca: il “caso Lucignano” prende forma
Con il passare dei decenni, la leggenda della Monna Lisa lucana divenne parte integrante del folclore locale, arrivando all’attenzione anche di media e studiosi al di fuori della Basilicata. Articoli di giornale, reportage e persino opere musicali si ispirarono a questa storia così romantica e inquietante allo stesso tempo . Negli anni 2000, mentre a Firenze gli archeologi iniziavano gli scavi alla ricerca dei resti di Lisa nel convento di Sant’Orsola, a Lagonegro la comunità locale rivendicava con orgoglio la propria versione dei fatti. Nel 2014 la cittadina lucana ha inaugurato addirittura un museo dedicato a Monna Lisa, allestito presso lo storico Palazzo Corrado, proprio per celebrare e far conoscere questa peculiare eredità leggendaria . L’apertura del Monna Lisa Museum di Lagonegro – con mostre ed eventi culturali – ha segnato il culmine di un “duello” culturale tra due regioni: da un lato la Toscana, forte delle nuove scoperte d’archivio, dall’altro la Basilicata, gelosa custode di un mito secolare . La vicenda infatti aveva ormai assunto i contorni di un giallo storico: le spoglie di Lisa Gherardini erano contese simbolicamente tra Firenze e Lagonegro, in una gara a chi potesse davvero fregiarsi del titolo di ultima dimora della Gioconda . In questo clima è nato il termine “caso Lucignano” – con riferimento al borgo toscano evocato nella leggenda – per indicare l’interesse verso l’ipotesi della sepoltura alternativa di Monna Lisa.
(Si noti che in realtà la località coinvolta dalla leggenda è Lagonegro, nell’antica Lucania, ma nell’immaginario popolare il nome Lucania talvolta è stato accostato a Lucignano, borgo toscano, creando una certa confusione. In questa sede, ci si riferisce al “mistero di Lucignano” come alla teoria che lega Lisa Gherardini a quella sepoltura fuori Firenze.)
Documenti, scavi e colpi di scena
Quali sono gli elementi a sostegno di questa teoria e quali quelli che la smentiscono? Dal lato di Lucignano/Lagonegro, l’ipotesi si è retta a lungo principalmente sul racconto tramandato e sulla suggestione storica. Fino a pochi anni fa, infatti, nessun documento certo contraddiceva apertamente la possibilità che Lisa fosse morta altrove: il suo certificato di morte e sepoltura non era stato trovato negli archivi fiorentini, e la voce lucana rimaneva perciò plausibile agli occhi di alcuni ricercatori . Soltanto nel 2007 un ricercatore fiorentino, Giuseppe Pallanti, ha finalmente rintracciato un atto d’archivio con il necrologio di Lisa Gherardini, confermando nero su bianco che morì a Firenze e fu “sotterrossi in Sant’Orsola” . Questa scoperta ha fornito la prima prova storica concreta a favore della versione fiorentina, smentendo di fatto la leggenda lucana . Parallelamente, gli scavi archeologici condotti nell’ex convento di Sant’Orsola fra il 2011 e il 2013 hanno riportato alla luce alcuni resti ossei compatibili con l’epoca in cui visse Lisa . Sebbene non sia stato possibile ottenere un’identificazione genetica certa, i risultati (come l’analisi al carbonio 14) hanno ulteriormente rafforzato l’ipotesi che la tomba autentica di Monna Lisa si trovi a Firenze . Di contro, a Lucignano/Lagonegro non si registrano scavi ufficiali: la cripta della chiesa di San Nicola non è mai stata aperta in epoca moderna alla ricerca di resti, e la “tomba segreta” rimane dunque tale – nascosta nell’ombra del mito. Gli unici “indizi” lucani restano le fonti letterarie e orali: il romanzo di Merežkovskij, le citazioni storiche come quelle di Carlo Pesce e la tenace convinzione popolare. Elementi affascinanti, ma insufficienti per risolvere con certezza il mistero.
Conclusioni: tra storia e leggenda
La vicenda della presunta tomba segreta di Lisa Gherardini a Lucignano rimane uno straordinario esempio di come storia e leggenda possano intrecciarsi. Da un lato abbiamo la verità documentata – quella della nobildonna fiorentina morta in età avanzata e verosimilmente sepolta a Firenze – dall’altro la potenza evocativa di un mito nato quasi per caso, ma capace di mettere radici profonde nell’immaginario collettivo. Ancora oggi, nonostante le prove emerse a favore di Firenze, il racconto della Monna Lisa morta lontano dalla sua città conserva un fascino poetico irresistibile. In Lucania si continua a ricordare con un certo orgoglio questa leggenda “alternativa”, quasi fosse un patrimonio segreto da custodire; a Firenze, al contempo, la vicenda è vista come una curiosità che arricchisce l’aura di mistero attorno alla Gioconda. In definitiva, il mistero di Lucignano – o meglio di Lagonegro – sopravvive nell’equilibrio tra realtà e fantasia. Pur smentita dagli studiosi, la storia della tomba nascosta di Monna Lisa continuerà a suggestionare appassionati di storia e curiosi, alimentando quella “disputa gentile” fra regioni che, senza alcuna ostilità, ha dato vita a un capitolo affascinante della storia culturale italiana . Come spesso accade con i grandi enigmi del passato, la leggenda talvolta resiste alla verità, trasformandosi essa stessa in parte della storia. E chissà che, nelle notti silenziose, tra i vicoli di Lucignano illuminati dalla luna, qualcuno non immagni ancora di scorgere l’ombra sorridente di Monna Lisa, a guardia del suo segreto sepolto sotto secoli di silenzio.
Fonti e riferimenti:
-
Iuri Lombardi, Monna Lisa: scoperta la vera sepoltura? – Nove da Firenze, 20 gennaio 2007
-
Pino Perciante, Duello con Firenze: «Monnalisa è sepolta a Lagonegro» – La Gazzetta del Mezzogiorno, 29 marzo 2013
-
Blog Sapri rovinata: La Gioconda di Leonardo da Vinci morta a Lagonegro (24 febbraio 2020), con citazioni da Carlo Pesce, Storia della città di Lagonegro (1914)
-
Lagonegro Cathedral, Wikipedia (EN), ultima modifica 2 nov 2024 – sezione sulla leggenda della tomba di Lisa del Giocondo
-
Redazione, Gioconda: il carbonio 14 rivela che la tomba di Monna Lisa è a Firenze – Rai News, 24 settembre 2015 .
Commenti
Nessun commento ancora. Sii il primo!
Per commentare devi accedere o registrarti.