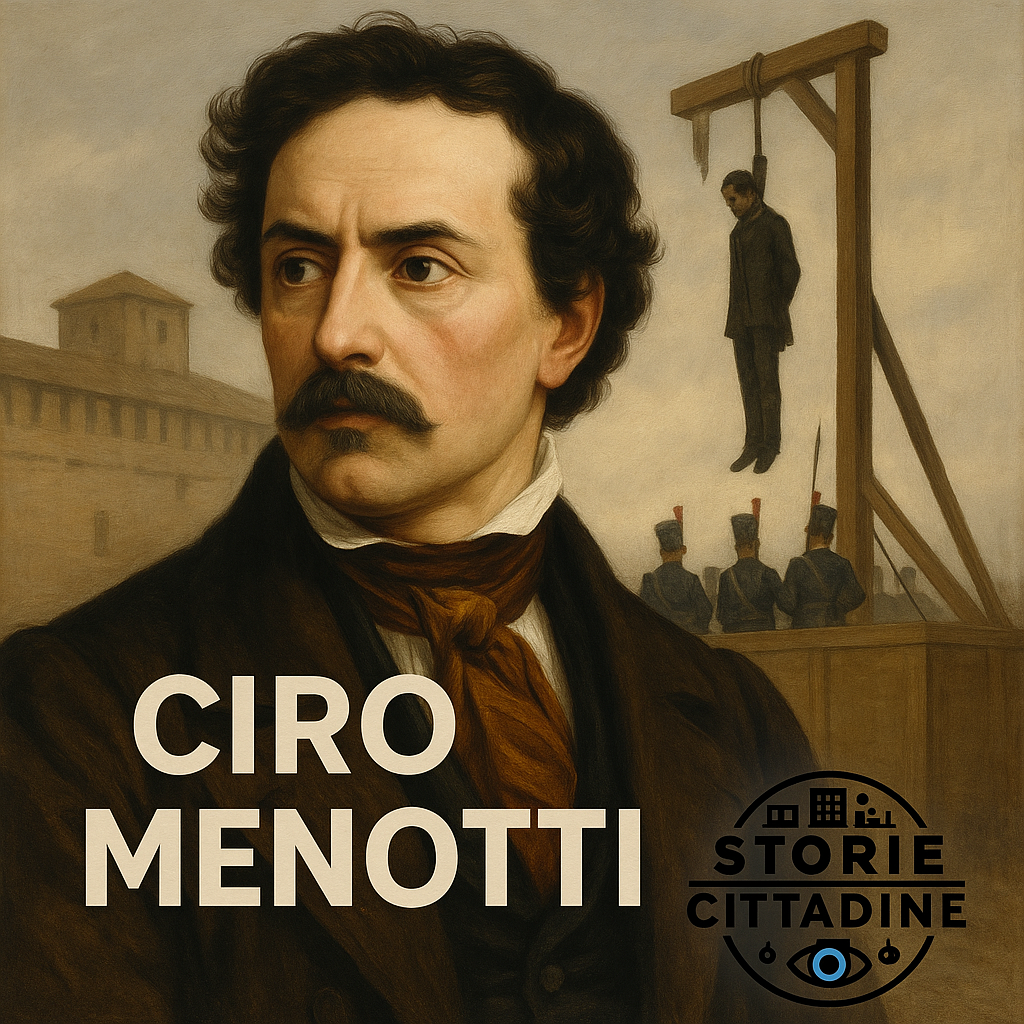
Ciro Menotti: da cospiratore a martire del Risorgimento
Pubblicata il 17/06/2025
L’Italia tra Restaurazione e primi moti rivoluzionari (1815–1831)
Dopo la caduta di Napoleone nel 1815, il Congresso di Vienna restaurò in Italia i vecchi regimi assolutistici, revocando le costituzioni e sopprimendo le libertà concesse in epoca rivoluzionariatreccani.it. In questo clima di reazione nacquero società segrete di ispirazione liberale e patriottica, come la Carboneria, che miravano a rovesciare i governi della Restaurazione tramite congiure e sollevazionitreccani.it. I moti carbonari esplosero così in diverse parti d’Italia: nel 1820-21 vi furono rivolte costituzionali nel Regno di Napoli e in Piemonte, inizialmente vittoriose ma presto soffocate dall’intervento armato dell’Austria su mandato della Santa Alleanzatreccani.it. Molti patrioti italiani subirono arresti, torture e carcere duro (come Silvio Pellico, incarcerato allo Spielberg) per la loro attività cospirativatreccani.it. Dopo alcuni anni di dura repressione, fu la Rivoluzione di Luglio del 1830 in Francia a riaccendere la speranza: il rovesciamento dei Borbone oltralpe incoraggiò nuovi moti liberali nella Penisola. All’inizio del 1831 insurrezioni scoppiarono in varie zone dell’Italia centro-settentrionale – dal Ducato di Modena alle Legazioni pontificie (es. Bologna) e al Ducato di Parma – nel tentativo di ottenere regimi costituzionali o l’indipendenza dagli Austriaci. In questo contesto si inserisce la figura di Ciro Menotti e la sfortunata ribellione da lui guidata a Modena nel 1831, uno degli episodi precoci del Risorgimento italiano.
Le origini e la vita privata di Ciro Menotti
Ciro Menotti nacque il 23 gennaio 1798 a Migliarina, una frazione di Carpi nel modeneseit.wikipedia.org. Proveniva da una famiglia agiata di commercianti: il padre Giuseppe aveva un’avviata attività di lavorazione del truciolo e produzione di cappelli di pagliatreccani.ittreccani.it. Dopo aver compiuto gli studi ginnasiali a Carpi, il giovane Ciro ebbe una breve esperienza come ufficiale nella Guardia ducale di Modenatreccani.it. Poco incline alla vita di corte, egli si dedicò presto all’imprenditoria, dimostrando intraprendenza e spirito innovativo. Nei primi anni 1820 costituì con un ex giacobino, Antonio Lugli, un’agenzia per spedizioni di merci che aprì ai prodotti paterni i mercati esteri (persino l’Inghilterra)treccani.it. Investì poi i suoi guadagni in vari settori: acquistò una vasta tenuta agricola a Saliceto Panaro e nel 1823 vi impiantò un allevamento di bachi da seta con relativa filanda, introducendo per la prima volta nel Ducato una macchina a vapore per filare la seta (un’innovazione tecnologica notevole)treccani.ittreccani.it. Aprì anche una distilleria (1825), una fonderia e una ferriera (1826), arrivando a impiegare complessivamente oltre mille operai nelle sue attivitàtreccani.ittreccani.it. La sua intraprendenza incontrò però ostacoli: alcuni impianti dovettero chiudere per circostanze sfavorevoli e per il mancato sostegno protezionistico da parte del duca Francesco IV d’Asburgo-Este, che pure si era mostrato interessato alle iniziative industriali di Menottitreccani.it.
Sul piano personale, Ciro Menotti fu descritto dai contemporanei come un giovane di carattere forte e virtuoso. Nel 1826 sposò Francesca Moreali, che gli aveva già dato un figlio (Achille) ed era rimasta da poco vedovatreccani.it. Dall’unione nacquero ufficialmente almeno due figli, Achille e Adolfo, e Menotti fu un marito devoto e un padre affettuoso. Nonostante la vita agiata, conservò modi semplici e un sincero sentimento religioso. Proprio nella fede e nella dedizione alla famiglia egli trovò conforto durante le avversità: anni dopo, nelle sue ultime ore, scriverà alla moglie parole colme di amore, invitandola a essere forte per il bene dei figli e a crescerli nella virtù e nella memoria del padreit.wikisource.orgit.wikisource.org.
Patriota e carbonaro: l’attività cospirativa di Menotti
Fin da giovane Menotti maturò idee liberali e patriottiche molto vive, opponendosi alla dominazione austriaca in Italiait.wikipedia.org. Già nel 1817 entrò nelle file della Carboneria, la società segreta che diffondeva ideali democratici e aspirazioni di indipendenza nazionaleit.wikipedia.org. La conoscenza con il rivoluzionario Antonio Lugli lo introdusse nell’ambiente delle cospirazioni: nel 1821 Menotti fu coinvolto in una retata della polizia ducale, sospettato di aver diffuso insieme ad altri un proclama (scritto in latino) rivolto ai soldati ungheresi dell’esercito austriaco, incitandoli alla ribellione contro il dispotismotreccani.ittreccani.it. Per questo episodio rischiò gravi conseguenze, ma continuò imperterrito la sua attività patriottica clandestina.
Durante gli anni Venti, Menotti stabilì contatti sempre più ampi con i circoli liberali sia italiani sia stranieri. Dal 1820 mantenne frequenti relazioni con ambienti liberali di Parigi e con gli esuli democratici italiani lì residenti, come la nobildonna Cristina Trivulzio di Belgiojoso e sua madre Vittoria Gherardiniit.wikipedia.org. Attraverso queste conoscenze, Menotti si collegò a una rete cospirativa internazionale che mirava a liberare l’Italia dal giogo austriaco e dagli assolutismi locali. Una svolta decisiva avvenne nell’ottobre 1829, quando Ciro conobbe l’avvocato Enrico Misley, un liberale modenese vicino alla corte ducaletreccani.it. Tramite Misley, Menotti entrò in rapporto con importanti esuli e patrioti italiani a Parigi e con settori favorevoli in Francia, elaborando un audace progetto di rivolta che avrebbe coinvolto più stati italiani. Questo complotto passò alla storia come “congiura estense”treccani.it.
Il piano dei congiurati era complesso e in parte paradossale: prevedeva infatti di sfruttare le ambizioni del duca Francesco IV di Modena per la causa italiana. In particolare, nei circoli liberali si ventilava l’idea di portare Francesco IV sul trono del Regno di Sardegna al posto di Carlo Alberto di Savoia-Carignano, considerato ormai screditato dopo il suo comportamento ondivago nei moti piemontesi del 1821treccani.ittreccani.it. Francesco IV, attraverso il matrimonio con Maria Beatrice di Savoia (figlia primogenita di Vittorio Emanuele I), vantava legami dinastici con i Savoia e nutriva aspirazioni da grande sovranoit.wikipedia.org. I patrioti come Menotti speravano che, lusingando tale ambizione, il duca potesse appoggiare un movimento rivoluzionario che unisse l’Italia del Nord sotto una monarchia costituzionale a lui affidatatreccani.ittreccani.it. In sostanza Menotti, pur di scuotere l’ordine imposto dalla Restaurazione, era disposto ad allearsi col duca stesso in un’operazione che avrebbe potuto portare a una monarchia liberale italiana con capitale a Roma, come delineato in un suo manifesto inviato a Parigi nel dicembre 1830treccani.ittreccani.it. In quel documento – intitolato Idee per organizzare delle intelligenze fra tutte le città d’Italia per la sua indipendenza, unione e libertà – Menotti prospettava l’unificazione nazionale sotto un monarca costituzionale e adottava come bandiera il Tricolore ornato di una croce, a simboleggiare l’unione di libertà e fede religiosatreccani.ittreccani.it.
La congiura del 1831 a Modena: Carlo Alberto e il doppio gioco del duca
All’inizio del 1831 la situazione sembrò propizia all’azione. Nel gennaio di quell’anno, mentre nelle Legazioni pontificie (le province di Bologna, Ferrara ecc.) crescevano fermenti rivoluzionari, Ciro Menotti decise di passare ai fatti e organizzò nei dettagli l’insurrezione nel Ducato di Modenait.wikipedia.org. Egli cercò di ottenere il più ampio sostegno popolare e coinvolse i neonati circoli liberali cittadini. La data fissata per la rivolta fu il 3 febbraio 1831. Quella sera Menotti radunò 57 congiurati armati nella sua abitazione di Modena, situata non lontano dal Palazzo Ducale, pronti ad assaltare il palazzo e catturare il duca Francesco IVit.wikipedia.orgtreccani.it. Va sottolineato che Francesco IV, pur essendo un conservatore legato agli Asburgo, fino a quel momento aveva tenuto con Menotti un atteggiamento ambiguo e tollerante. Probabilmente, tramite l’intermediazione di Misley, il duca era stato informato del progetto rivoluzionario e lo aveva tacitamente assecondato, intrigato dalla possibilità di trarne vantaggio per séit.wikipedia.org. Altrimenti – osservano gli storici – è difficile spiegare perché Francesco non fece arrestare subito Menotti (che ben conosceva), quando in passato non aveva esitato a reprimere duramente anche minori sospetti di cospirazioneit.wikipedia.org. Questo doppio gioco faceva parte della strategia del duca: egli lusingava i liberali fingendo simpatia, ma al contempo restava pronto a tradirli se le circostanze fossero cambiateit.wikipedia.orgit.wikipedia.org.
In effetti le circostanze mutarono bruscamente proprio in quei giorni. L’improvviso scoppio della rivoluzione liberale a Bologna il 4 febbraio 1831 spaventò Francesco IV, facendogli temere che i moti potessero dilagare rendendo ingestibile la situazionetreccani.it. Inoltre, l’ascesa al trono di Carlo Alberto in Piemonte (divenuto re il 27 marzo 1831 dopo la morte di Carlo Felice) non stava affatto portando l’appoggio sperato: Carlo Alberto, pur avendo avuto trascorsi liberali, in quel frangente non offrì alcun sostegno concreto ai rivoluzionari italiani. Anzi, per legittimare il proprio regno, egli si allineò all’atteggiamento conservatore richiesto dall’Austria e dalla Santa Alleanza. Le aspettative che alcuni patrioti riponevano in lui si rivelarono vane: nessun aiuto arrivò dal Piemonte alle insurrezioni del 1831, e Carlo Alberto – che pure avrebbe guidato l’Italia anni dopo – in quel momento lasciò che l’ordine assolutistico fosse ristabilito, tradendo di fatto le speranze liberali.
Francesco IV dunque decise di rompere gli indugi e il 3 febbraio 1831 attuò il suo tradimento. Invece di farsi trovare impreparato, la sera stessa in cui Menotti e i suoi scendevano in campo, il duca fece circondare dalla truppa la casa di Menotti e ordinò di attaccare i congiurati. Ne seguì uno scontro a fuoco: i patrioti, colti di sorpresa, tentarono di resistere e poi di fuggire. Tre soldati ducali e un rivoluzionario rimasero uccisi nella sparatoriatreccani.it. Molti cospiratori riuscirono a dileguarsi, ma Ciro Menotti no: saltato da una finestra nel giardino, si ferì cadendo ed fu catturato insieme ad altri compagni (in tutto 44 arrestati quella notte, cui se ne aggiunsero altri 23 il giorno seguente)treccani.it. Francesco IV rivelò immediatamente il suo atteggiamento spietato: quella stessa notte scrisse concitato al governatore di Reggio un ordine che suonava come una condanna anticipata, dichiarando: «Questa notte è scoppiata contro di me una terribile congiura. Mandatemi il boia»it.wikipedia.org. Eppure, nel giro di poche ore, gli eventi lo indussero a cambiare nuovamente tattica: saputo che la rivolta aveva trionfato a Bologna e temendo l’arrivo di colonne di insorti verso Modena, il duca preferì fuggire precipitosamente dal suo Stato il 5 febbraio 1831treccani.ittreccani.it. Riparò a Mantova (territorio austriaco) portando con sé Ciro Menotti prigioniero, mentre gli altri congiurati rimasero nelle carceri di Modena in attesa degli sviluppitreccani.it.
La fuga di Francesco IV confermò i sospetti di un suo coinvolgimento nella congiura precedentemente. Infatti, appena il duca lasciò Modena, i patrioti locali proclamarono la decadenza del suo governo e instaurarono un governo provvisorio: il notaio Vincenzo Borelli redasse l’atto ufficiale di deposizione il 9 febbraio, firmato anche dal fratello di Ciro, Celeste Menotti, e dal capo provvisorio Biagio Narditreccani.ittreccani.it. Modena e le province insorte sperarono nell’intervento di Carlo Alberto o almeno in un accordo con i Savoia, ma ciò non avvenne. Invece, furono le truppe austriache a intervenire come “gendarme d’Europa”: nel giro di qualche settimana, su invito dello stesso Francesco IV e della Santa Alleanza, l’esercito austriaco marciò nei ducati e nelle Legazioni ristabilendo l’ordine assolutista. Alla fine di marzo 1831 la rivoluzione era ovunque domata. Francesco IV rientrò trionfante a Modena il 9 marzo 1831, di nuovo saldo sul trono, e con sé riportò il prigioniero Menotti, deciso a fargliela pagare.
L’arresto, il processo e l’esecuzione di Menotti
Con il ritorno del duca, il destino di Ciro Menotti era segnato. Già durante l’esilio a Mantova, Francesco IV aveva emanato decreti che condannavano Menotti in contumacia. Appena rientrato, istituì una Commissione militare straordinaria per giudicare rapidamente i ribelli con un processo sommario (statario)treccani.it. Il processo a carico di Menotti si aprì ufficialmente il 25 aprile 1831 a Modena. L’imputato fu accusato di lesa maestà (alto tradimento) e di resistenza a mano armata contro il sovranotreccani.it. Menotti fu assistito da un difensore d’ufficio che tentò invano di contestare la legittimità del tribunale, visto che il duca aveva già dichiarato colpevole l’accusato con un rescritto del 12 febbraiotreccani.it. Nel dibattimento Ciro cercò fino all’ultimo di salvarsi invocando proprio il progetto originario della congiura: egli sostenne davanti ai giudici che il suo scopo principale era stato ingrandire il potere del duca, non abbatterlotreccani.it. In altre parole, Menotti affermò di aver agito per la gloria di Francesco IV (volendolo fare re di un più vasto regno) e non per mero spirito sovversivo, sperando così nella clemenza del principe. Ma queste giustificazioni non gli valsero alcuna grazia. Pare che anche il vescovo di Modena si sia appellato al duca per risparmiare la vita al prigioniero, ma Francesco IV fu irremovibiletreccani.it. Probabilmente il duca giudicava Menotti un testimone ormai troppo pericoloso: perdonarlo avrebbe significato ammettere i propri precedenti contatti con i rivoluzionari, mentre eliminarlo per sempre garantiva di cancellare quella scomoda veritàtreccani.it.
Il verdetto fu emesso il 9 maggio 1831: condanna a morte di Ciro Menotti per impiccagionetreccani.it. Altri cospiratori, inizialmente condannati a morte con lui (come Luigi Adami, Giuseppe Brevini, Antonio Giacomozzi), ottennero in extremis la commutazione della pena in carcere duro, ma per Menotti non ci fu scampoit.wikipedia.org. Un tentativo di farlo evadere dal carcere il 28 febbraio era già fallitoit.wikipedia.org. Numerose suppliche per la grazia giunsero a Francesco IV da ogni parte – sia da famiglie influenti sia da governi stranieri – ma nulla scalfì il proposito punitivo del ducait.wikipedia.org. La sentenza capitale fu tenuta segreta fino all’ultimo momento per evitare sommosse: fu resa pubblica solo a esecuzione avvenutait.wikipedia.org.
All’alba del 26 maggio 1831 Ciro Menotti fu condotto al patibolo. Aveva 33 anni. L’esecuzione avvenne entro le mura della Cittadella di Modena, su un bastione, alla presenza di un picchetto di soldati e di pochi testimoni ammessi. Insieme a Menotti fu giustiziato anche Vincenzo Borelli, il notaio colpevole di aver redatto l’atto di decadenza del duca durante la sua fuga: anche per lui fu fatale l’aver creduto nella causa di libertàtreccani.it. Menotti affrontò la morte con dignità e coraggio, sorretto dalla fede. Trascorse la notte precedente in preghiera assistito dal sacerdote don Francesco Bernardi, al quale affidò un’ultima, toccante lettera per la moglieit.wikipedia.org. In quelle righe d’addio, scritte poche ore prima di morire, egli riversò tutto il suo amore e la sua forza d’animo. «Carissima moglie, la tua virtù e la tua religione sieno teco e ti assistano nel ricevere questo mio foglio – Sono le ultime parole dell’infelice tuo Ciro», esordì, esortando la consorte Francesca a farsi coraggio e a vivere per i figli, “facendo loro da padre” d’ora in poiit.wikisource.org. La supplicò di non abbandonarsi al dolore ma di vincerlo in nome suo, e di far sapere ai bambini, quando fossero cresciuti, che il loro padre era stato “uno che amò sempre il suo simile”it.wikisource.orgit.wikisource.org. Confidò di affrontare la fine con fede in Dio, considerandola il premio del giusto, e di sentirsi pronto al passo estremoit.wikisource.org. In un passaggio straziante, le inviò in ricordo una ciocca dei suoi capelli come “ultimo pegno” d’amore, da distribuire ai familiariit.wikisource.org. «Addio per sempre, Cecchina… Ama sempre la memoria dell’infelice tuo Ciro», concluse, firmando di suo pugno il messaggio d’addioit.wikisource.org. Questa lettera, subito sequestrata dalla polizia estense, non giunse nelle mani della moglie fino a 17 anni dopo: fu infatti recuperata solo nel 1848, quando la fuga finale del duca Francesco V (figlio di Francesco IV) permise di aprire gli archivi segreti e restituire ai Menotti quel prezioso documentoit.wikipedia.org.
All’ora stabilita, Menotti salì al patibolo con fierezza. Il boia eseguì la sentenza impiccandolo di fronte alla fortezza: erano circa le 7 del mattino del 26 maggio 1831. Il corpo di Ciro, secondo l’uso riservato ai giustiziati, fu sepolto in terra sconsacrata. Solo molti anni dopo, nel clima mutato del 1848, i suoi resti vennero esumati e trasferiti dalla fossa comune al cimitero della tenuta di famiglia a Spezzano, presso Fiorano Modenesetreccani.it. Così si chiudeva tragicamente la vicenda umana di Ciro Menotti, una delle prime vittime illustri del Risorgimento italiano.
Da cospiratore a martire: la memoria di Ciro Menotti
La figura di Ciro Menotti, inizialmente bollato dal regime estense come un traditore ribelle, divenne ben presto un simbolo di martirio patriottico per gli italiani. Nell’immaginario dell’Ottocento, Menotti fu esaltato come un rivoluzionario impavido e un eroe romantico, precursore non solo dei moti del 1831 ma dell’intero movimento risorgimentaleit.wikipedia.org. I patrioti delle generazioni successive lo annoverarono nel pantheon degli eroi nazionali: Giuseppe Garibaldi volle addirittura battezzare Menotti il suo primogenito, in onore del martire modeneseit.wikipedia.orgen.wikipedia.org. Nelle scuole dell’Italia unita si celebrava il suo sacrificio come esempio di amor di patria: fin dalle elementari, i bambini leggevano la sua commovente lettera alla moglie, imparando ad ammirarne la virtù e il coraggio supremiit.wikipedia.org.
A Modena e in tutta Italia, col passare degli anni, la memoria di Menotti venne riabilitata e onorata pubblicamente. Nel 1879, a pochi anni dall’unità nazionale, un comitato di cittadini finanziò l’erezione di un grande monumento in bronzo dedicato a Ciro Menotti, opera dello scultore Cesare Sighinolfiit.wikipedia.org. La statua venne collocata a Modena in piazza Roma, proprio di fronte all’ingresso del Palazzo Ducale, quasi a sfidare idealmente il luogo dove il duca firmò la condanna a morte dell’eroeit.wikipedia.org. Menotti è raffigurato col viso accigliato rivolto verso le finestre del palazzo e con in mano il Tricolore, il vessillo per cui sacrificò la vitatreccani.it. Nel discorso inaugurale del monumento (avvenuta nel 1880) fu sottolineato come quel giovane imprenditore, un tempo considerato un “cospiratore”, fosse ora riconosciuto quale martire della libertà e padre spirituale dell’Italia unita.
Anche i luoghi legati alla sua storia divennero spazi di memoria. La casa di Menotti a Modena – in corso Canal Grande n.90 – reca una lapide commemorativa in ricordo della riunione dei patrioti e del suo arresto: restaurata nel 2007, testimonia tuttora quegli eventiit.wikipedia.org. Il punto esatto della Cittadella dove fu innalzata la forca nel 1831 è stato anch’esso risistemato e segnato da un monumento moderno: nel 2007, con una cerimonia alla presenza delle autorità e di discendenti della famiglia Menotti, è stata inaugurata un’installazione in pietra che riprende i gradini del patibolo, illuminata dai fari con i colori nazionali verde-bianco-rossoit.wikipedia.orgit.wikipedia.org. Questo a suggellare come, a distanza di quasi due secoli, la città di Modena consideri Ciro Menotti non più un suddito ribelle, ma un eroe del Risorgimento da onorare.
Nel corso del tempo, la vicenda di Menotti ha ispirato numerosi libri, canti popolari, poesie e opere teatrali. Già nel 1848 lo storico Atto Vannucci lo incluse nei suoi Martiri della libertà italiana, contribuendo a diffonderne la famait.wikipedia.org. Biografie e studi successivi ne hanno approfondito le gesta e il significato storico. Ancora oggi, Ciro Menotti rimane un simbolo luminoso di amore per la patria e di sacrificio per gli ideali di libertà e unità nazionale. La sua vita – dall’intensa attività cospirativa alla morte sul patibolo – rappresenta uno dei primi capitoli del difficile cammino che porterà, qualche decennio dopo, alla nascita di un’Italia libera e unita. Come egli stesso profeticamente scrisse, i suoi figli e la sua gente avrebbero avuto pietà e rispetto dopo la sua morte più di quanto ne ebbe vivendoit.wikisource.org. Oggi la memoria collettiva non ricorda più un “ribelle” sconfitto, ma onora in Ciro Menotti il martire del Risorgimento che, con coraggio e spirito di abnegazione, seppe anteporre il sogno di un’Italia libera al proprio destino personaletreccani.it. Le sue ultime parole e il suo esempio continuano a commuovere e a ispirare, rendendo vivo il suo nome nella storia d’Italia.
Fonti: Archivio di Stato di Modena; Enciclopedia Treccani; Museo del Risorgimento di Modena; C. Menotti, “Lettera alla moglie” (1831); Atto Vannucci, I martiri della libertà italiana (1860).
Commenti
Nessun commento ancora. Sii il primo!
Per commentare devi accedere o registrarti.